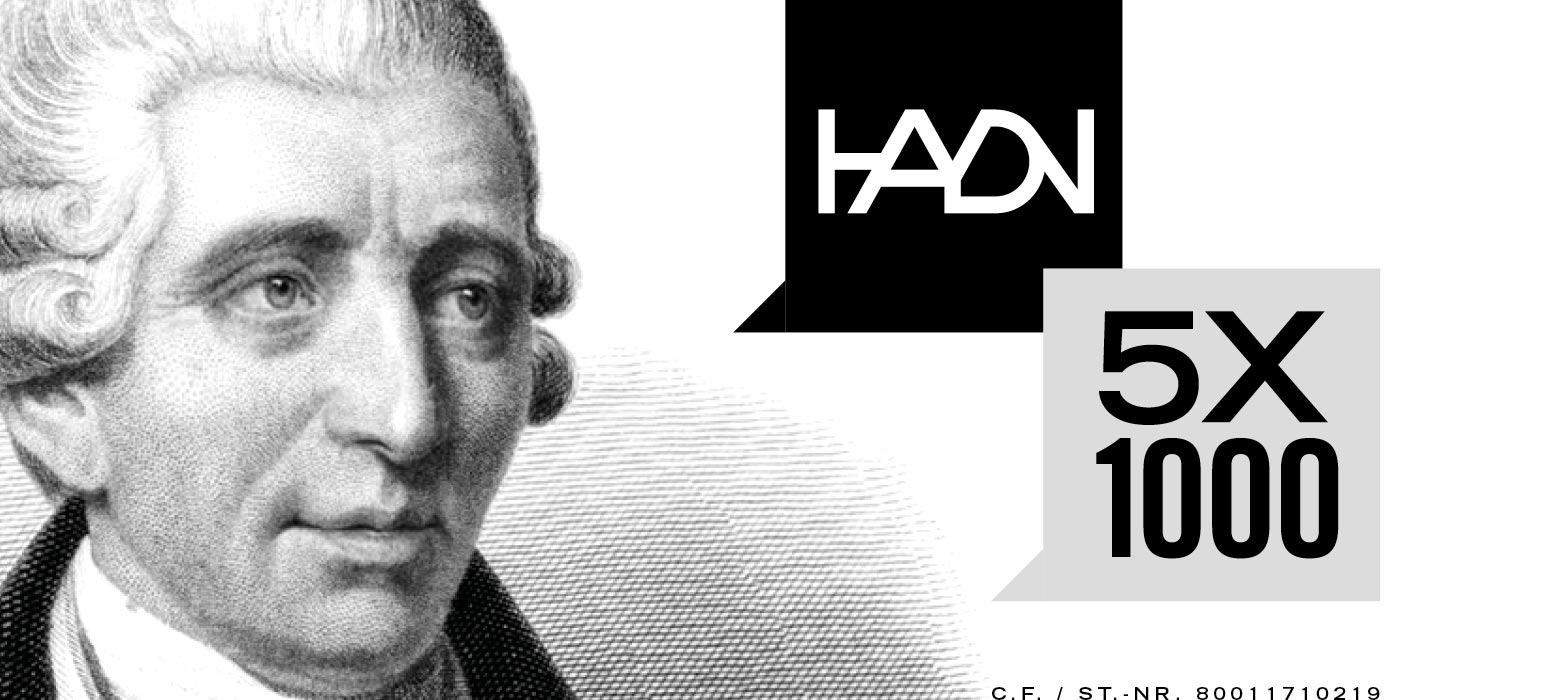Le trascrizioni per orchestra dei canti popolari dell’arco alpino: in conversazione con Armando Franceschini
Sappiamo come il rapporto tra musica classica e tradizione popolare abbia attraversato la storia e l’evoluzione stilistica dell’arte musicale attraverso i secoli. Si tratta per lo più di un percorso carsico, immerso tra le pieghe di un territorio culturale profondamente interconnesso, protagonista di volta in volta di emersioni che divengono, per rilevanza e originalità, elementi emblematici e caratterizzanti nel tracciato storico-musicale. Così, solo per evocare qualche esempio di ambito europeo, dal periodo rinascimentale costellato, tra le diverse declinazioni polifoniche, di strambotti, villotte e villanelle si arriva all’immaginario espressivo di un compositore come Gustav Mahler, dove si incontrano tradizione austro-tedesca e riferimenti alle radici ebraiche, alla musica klezmer e alla musica popolare morava, passando per il fascino esercitato in maniera affatto differente dalla musica popolare ungherese su due autori come Johannes Brahms e, soprattutto, Béla Bartók, quest’ultimo caratterizzato da un linguaggio musicale che si fonda su un originale rapporto fra la tradizione colta e i canti popolari che ha raccolto sul campo in Ungheria.
In questa prospettiva si colloca l’antologia di melodie scelte, armonizzate e orchestrate da Armando Franceschini, compositore e didatta, già docente presso i Conservatori di Mantova e Parma e, dal 1982, titolare della cattedra di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il Conservatorio di Trento del quale, dal 1989 al 2006, ha assunto anche la direzione.